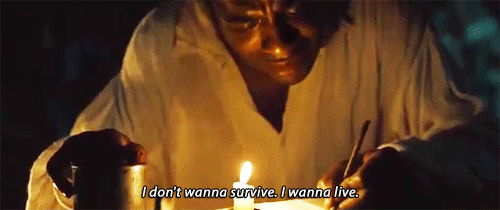I libri - le storie che ho amato durante la mia vita - hanno avuto a che fare con me sia perché fondavano un nuovo modo di guardare il mondo, sia perché chiarivano almeno un po' quello che avevo compreso (o non avevo compreso) fino a quel momento.
Il 22 giugno 1974, al settantottesimo minuto di una partita di calcio, sono diventato comunista.
Mio padre penserà sempre due cose ossessivamente: una, che se viene veramente il comunismo si scoprirà che in fondo nessuno è comunista; e l'altra, più pericolosa e più martellante nei miei confronti, che il comunismo è un sistema di divisione continua, meticolosa e ossessiva, di qualsiasi cosa si venga in possesso, volontariamente o involontariamente. Ed è per questo sistema morboso della divisione che pensa che se viene il comunismo poi nessuno vuole essere comunista. [...]
Dirà: fai il comunista - non ce l'avrà con me, quando parlerà con il tu non ce l'avrà mai con me. Anche in questo sarà strano: quando parlerà di altri comunisti, mi guarderà in faccia e dirà: fai il comunista e tieni due macchine, perché non ne dai una a un operaio? - e so che non ce l'ha con me, perché io due macchine non ce le ho, nemmeno una se è per questo, e perciò andrò a chiedergli le chiavi della macchina e lui dirà che faccio il comunista con le chiavi della macchina di papà. Invece, quando ce l'avrà con me, guarderà nel vuoto, come se stesse parlando di me a un altro, e dirà: fa il comunista, lui, e poi mi viene a chiedere le chiavi della macchina. Per mio padre, in modo ossessivo, e per tutta la vita, se uno è comunista non potrà mai chiedere le chiavi della macchina. E qualora dovesse avere una macchina, poi, il bollo lo dovrà pagare Berlinguer. Se ne avrà due, dovrà darne una a un operaio. [...]
Per il resto del tempo, per tutta la vita, mio padre continuerà a guardarmi fisso con le braccia incrociate. E aspetterà. Aspetterà che viene veramente il comunismo per vedere se io sono davvero comunista.
Aspetterà, tra l'altro, inutilmente.
L'unità dei partiti di sinistra non è sufficiente, se si contrappone a essa un'alleanza che va dal centro fino all'estrema destra. Il problema in Italia è sempre stato questo: evitare la saldatura tra il centro e la destra, e «riuscire invece a spostare le forze sociali e politiche che si situano al centro su posizioni coerentemente democratiche». Berlinguer dice con molta chiarezza che una garanzia di democrazia non esisterebbe nemmeno se la sinistra unita raggiungesse il cinquantuno per cento dei voti. «Ecco perché noi parliamo non di una "alternativa di sinistra", ma di una "alternativa democratica" e cioè della prospettiva politica di una collaborazione e di una intesa delle forze popolari di ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico».
Le condizioni, quando sono diventato comunista, erano queste. Non che ne fossi consapevole, o mi potessi arrischiare a leggere Rinascita; ma l'aria che cominciai a respirare aveva due caratteristiche: il dialogo (il compromesso), e il progresso (contro i conservatori, contro i reazionari). In quei tre articoli, che fondavano la politica di quegli anni, la novità era il tentativo di allearsi con la Democrazia cristiana favorendone la parte progressista, per diventare una doppia forza che avrebbe governato l'Italia per molti anni (con la speranza, successiva, di conquistare la fiducia degli italiani e proseguire, in futuro, da soli); la base su cui si proponeva questa novità era la necessità di trasformare il Paese, di cambiarlo, di spingerlo in avanti - in opposizione al freno reazionario che attraversava da sempre l'Italia. Il compromesso storico era la soluzione per alimentare in modo concreto l'idea del progresso, per combattere in modo concreto gli intenti reazionari. Era quindi un'aria palpabile e viva.
Se fossi stato costretto a sintetizzare la decisione di essere diventato comunista - quando ne sono diventato consapevole, negli anni successivi al gol di Sparwasser -avrei detto così: mio padre vuole che il mondo dove viviamo resti com'è, sempre uguale; io voglio cambiarlo, farlo diventare migliore.
Mentre Leone e la Cederna litigavano, mentre zio Nino e zia Rosa litigavano, Berlinguer e Moro stavano portando a compimento il compromesso storico. Dopo un governo presieduto da Andreotti e chiamato di "non sfiducia" (i partiti di opposizione si astenevano dal voto in aula), il presidente del Consiglio si era dimesso, e adesso, dopo lunghe trattative, si stava per compiere il cammino che Berlinguer aveva intrapreso dai fatti del Cile in poi. Il suo interlocutore era stato sempre Aldo Moro, in questo momento presidente della Democrazia cristiana e convinto sostenitore dell'alleanza con i comunisti. In pratica, da quando alle elezioni del 1976 il Pci si era avvicinato così tanto alla Dc, la soluzione di Moro per continuare a fare in modo che la Democrazia cristiana conservasse il potere in Italia, era non contrapporsi più al Pci, rischiando un giorno non soltanto di perdere le elezioni, ma di lasciare campo libero in Italia a chissà quale incognita. Moro ragionava cosi: la clausola "ad excludendum" deresponsabilizza il Partito comunista; non solo: gli dà la possibilità di giudicare di continuo l'operato dei partiti di governo, come se vivesse di rendita sugli errori degli altri; ed era questo, secondo lui, ciò che stava succedendo, e il motivo per cui i voti al Pci si allargavano ogni volta oltre il suo bacino. L'esclusione a priori del Pci lo rendeva un partito populista, senza responsabilità - è questo che Moro spiega in un incontro difficilissimo e decisivo con i deputati e i senatori della Democrazia cristiana. Li ha riuniti con l'intento ultimo di neutralizzare le forti resistenze delle altre correnti di partito all'idea di un cammino condiviso con i comunisti. Il suo discorso politico è nitido: non è una soluzione estrosa, dice, ma necessaria. Se noi ci alleiamo con il Partito comunista, possiamo conservare il potere e il controllo sul Paese per molti altri decenni. E solo con un'alleanza governativa terremo a bada i nostri antagonisti. Quindi fa intravedere al suo partito un possibile scenario apocalittico (la Democrazia cristiana che viene estromessa dal potere, e per giunta dai comunisti) oppure un possibile scenario radioso (la Democrazia cristiana, alleandosi con il suo maggiore avversario, non lascerà il potere mai più). Del resto, Moro aveva detto una volta: «La Democrazia cristiana è come un'ameba che tende sempre ad appoggiarsi a quello con cui sta in quel momento». Era arrivato il tempo di appoggiarsi a un partito con energia viva, intatta; e ormai grande come il suo.
Poi per fortuna, vennero in soccorso tutti. Vennero in soccorso anche - subito, devo dire, ma giusto in tempo - di quel minuscolo pensiero che stava per fare capolino nella mia testa, e che solo grazie all'entità della tragedia e al coinvolgimento serio e non polemico di mio padre, ero riuscito per ora a respingere: e cioè, che se il comunismo stava per arrivare veramente, come diceva lui, e stava per arrivare in questo modo, allora davvero non stavo già più da quella parte, ma stavo insieme a mio padre, e a quasi tutti gli altri. In questo momento, pur avendo creduto di essere diverso, il mio unico desiderio era di essere come tutti. Come mio padre e mia madre, come i vicini, come quelli che parlavano al telegiornale. Come zio Nino. E come zia Rosa.
Oltretutto, il legame con Berlinguer si era fatto più intimo, perché avevo visto i suoi occhi intristirsi e la solitudine di noi comunisti - una solitudine nei confronti del mondo - farsi più evidente. In qualche modo, Berlinguer mi commuoveva perché mostrava orgoglio e forza, energia viva che ci spingeva a pensare ancora che un giorno sarebbe finalmente accaduto chissà che - ma la verità era che l'occasione era andata perduta, e vivevamo una specie di vita postuma, in cui non bisognava dirlo e nemmeno pensarlo che l'occasione era andata perduta.
Il compromesso storico era nato ufficialmente nei giorni del colera, e moriva ufficialmente nei giorni del terremoto. Ma solo ufficialmente, perché in tutta evidenza era morto prima: insieme ad Aldo Moro.
Senza possibile scarto di errore, posso dire che il pomeriggio del 13 giugno, nel momento preciso in cui ho alzato il pugno da solo nella camera da letto dei miei genitori, ho smesso di essere giovane. Avevo vent'anni esatti, e sono diventato adulto, in un modo aggrovigliato. Sia chiaro: ho schiacciato il groviglio sotto il peso delle convinzioni, ma il groviglio si era ormai formato in modo ineliminabile, ha atteso di essere compreso in seguito e poi in qualche modo risolto - e chissà se adesso, mentre scrivo dopo tanti anni, è stato davvero risolto. Da quel pomeriggio, la politica è diventata un elemento quotidiano della mia vita, me ne sono occupato come ci si occupa dei figli, perché li ami e perché lo devi fare. Non sono riuscito più a percepire in me una vita privata, se non legata in modo indissolubile a ciò che accadeva nel Paese; e non sono mai più tornato indietro. E come se quel pomeriggio si fossero interrotte le storie della mia formazione. Non sarei riuscito più a delimitare il campo, a produrre esperienze personali che non fossero in relazione con un sentimento più generale, quasi sempre malinconico. Come se avessi avuto sempre qualcos'altro da pensare accanto agli studi, poi al lavoro, agli innamoramenti, ai litigi in famiglia, alle feste natalizie - qualcosa che voleva dare un senso ulteriore a quello che facevo nella mia città, con i miei amici. Ma che rendeva alla fine tutto insoddisfacente. La sensazione era che la vita si era ristretta, diventando adulti. I fatti diminuivano e aumentavano i ragionamenti sui fatti. La sensazione era anche che la vita diventava più costante, scandita dall'abitudine. E le novità erano fuggevoli, oltre che rare. Come se tutto dovesse svolgersi con più precisione, meno sorpresa.
Qualcosa se n'era andato via per sempre con Berlinguer. Le cose accadevano intorno a me, le valutavo; e le valutavo secondo le nuove regole: non dovevo compromettermi con quello che non mi piaceva, dovevo combattere - o meglio, lamentarmi - del mondo com'era diventato. Ripetevo la parola che condiva ogni discorso dei comunisti che si stavano trasformando in persone più genericamente di sinistra perché il mondo cambiava: ormai, dicevamo. Come se tutto il senso delle cose fosse (ormai) alle spalle.
In Vecchie carte da gioco Rosellina Balbi affronta la questione di cosa significhi essere di sinistra. E soprattutto quella che definisce «la tragedia dell'eguaglianza». Conclude l'articolo così, sotto il mio evidenziatore giallo ben calcato: «Personalmente, sono ancora e sempre del parere che la distinzione da fare sia quella tra l'eguaglianza e il diritto all'eguaglianza: la prima non esiste (per fortuna): ciascuno di noi deve fare la sua corsa e arrivare dove potrà, saprà e vorrà. Altra cosa è la parità delle condizioni di partenza: è questo che la sinistra deve ottenere, così come deve continuare a battersi perché la innegabile diversità tra gli uomini non diventi pretesto per la discriminazione e il sopruso dei forti nei confronti dei deboli».
Dall'entrata mancata nel governo e dal rapimento di Moro, nasce un'idea di purezza - interpretata come un destino - che non morirà più. Quello che Moro aveva temuto, si verifica alla lettera: il Pci diventa interlocutore esterno della realtà. Ma quello che Moro indicava come un pericoloso punto di forza, diventa una condanna alla marginalità, alla sconfitta.
E qui che sta il grande cambiamento: della vittoria non importava più nulla; bisognava soltanto segnare una volta e per sempre una linea di demarcazione, un'idea definitiva di diversità; bisognava sfilarsi dalla vita pubblica reale e rappresentare un'alternativa astratta, pulita, arroccata. Un'alternativa pura.
Da quel momento in poi, ogni sconfitta politica diventa un rafforzativo delle proprie idee. Una conferma che il mondo è corrotto e che il progresso è malato. Una conferma, quindi, che le persone giuste e i pensieri giusti sono minoranza, fanno parte di un mondo altro, che non comunica più con il Paese - perché il resto del Paese, impuro e corrotto, si è perduto.
Adesso Bertinotti questo potere ce l'ha (grazie a me) e se lo sta prendendo tutto. Sta facendo ciò che desidero con tutte le forze che non faccia, ma sono io che gli ho dato facoltà di farlo. [...]
Il governo perde per un solo voto, 313 no contro 312 si, e Prodi va a rassegnare le sue dimissioni. [...]
D'Alema ottiene anche altri due risultati inconfutabili: l'idea che il centrosinistra, pur di restare al potere, è disposto ad allearsi con chiunque; e l'idea che in tempi di bipolarismo di fatto, quando un governo perde la fiducia dei partiti grazie ai quali ha conquistato la maggioranza, si dovrebbe tornare a votare.
Con questi criteri, siamo diventati la parte più reazionaria del Paese, nonostante ci fossimo definiti moderni, oltre che civili. In pratica, abbiamo cominciato a fare resistenza al malcostume, alla degenerazione, e pian piano la resistenza è diventata la nostra caratteristica principale, che è tracimata anche nel costume, in ogni forma di cambiamento, di accadimento. Abbiamo cominciato perfino a usare la parola: resistere - che è diventata senso di estraneità a tutto. Diamo l'impressione, al resto del Paese, di giudicarlo male qualsiasi cosa provi a fare; di essere scandalizzati, a volte inorriditi.
A noi della sinistra italiana, nella sostanza, non piacciono gli italiani che non fanno parte della sinistra italiana.
Non li amiamo. Sentiamo di essere un'oasi abitata dai migliori, nel mezzo di un Paese estraneo. Di conseguenza sentiamo di non avere nessuna responsabilità. Se l'essere umano di sinistra sentisse una correità, non penserebbe di voler andare a vivere in un altro Paese, più degno di averlo come cittadino. Però, a questo Paese che non ci piace, che non possiamo amare, del quale non sentiamo di far parte, e che osserviamo inorriditi ed estranei, noi della sinistra italiana a ogni elezione, siamo costretti a chiedere il voto. Vogliamo, cioè, che quella parte di Paese che disprezziamo, si affidi alle nostre cure. Ciò che puntualmente non avviene, proprio perché il resto del Paese sente questo senso di estraneità. E poiché non avviene, noi della sinistra italiana ci indigniamo di più, ci estraniamo di più e riteniamo di essere ancora meno responsabili di questo Paese di cui non sentiamo di far parte.
All'improvviso, mi sembrava che avere quella fragilità paradossale che attribuiamo a chiunque abbia potere e quindi è obbligato a fare - fragilità dal punto di vista etico, dal punto di vista delle contraddizioni, della distanza tra le promesse e la loro fattibilità - fosse infinitamente meglio che avere quella forza di chi è senza responsabilità, e il suo obiettivo è proprio quello di attraversare l'intera vita senza prendersi neanche una responsabilità attiva, e così appare alla fine come colui che non ha mai sbagliato: un Giusto, appunto.
Ho capito che piegarsi era infinitamente più virtuoso e utile che non piegarsi. Ho capito che la testardaggine di non tradire se stessi (l'etica dei principi) era in contraddizione con la necessità di non tradire milioni di persone (l'etica della responsabilità).
I libri che Elena mi assegnava erano testi fondamentali; ma oltre a insegnare ciò che insegnavano, mi davano un messaggio di secondo grado, troppo a lungo sottovalutato: ciò che leggevo, su cui mi formavo, confermava ossessivamente il mio pensiero. Non lo metteva in discussione, non lo rendeva problematico, ma facendolo crescere mi rassicurava ogni giorno di essere sempre e soltanto dalla parte della ragione. Questa idea del pensiero confermativo è, in seguito, in qualche modo esplosa, perché ha formato una classe intellettuale ampia che legge giornali confermativi e scrive su quei giornali ragionamenti confermativi. Tutto ciò, anno dopo anno, rende impermeabili al confronto, alla curiosità per gli altri, per le vite diverse; e rende sempre più sicuri di ciò che si pensa, di come si vive, delle regole che ci si è dati.
Di conseguenza, il campo dei nostri desideri, mentre viene soddisfatto di continuo, si restringe; di conseguenza, ci sembrerà che nel mondo c'è soltanto gente che la pensa come noi.
Se ho ritenuto di poter mettere in campo una disonestà, è stato perché non ritenevo degne di onestà quelle persone, non le ritenevo mie pari. Poiché erano fasciste, ero autorizzato a essere disonesto con loro. Era questa posizione che mi metteva a disagio, quando me ne sono reso conto. Ma è la posizione che abbiamo avuto tutti, per venti anni, con il mondo che non ci piaceva.
Avevo partecipato anch'io, come tutti, in qualche modo, alla costruzione dell'Italia così come la vedo, sia avendo ridotto il senso della tragedia, sia con lo strumento della superficialità, sia per le continue assenze, sia per aver goduto di ogni cosa.
In questi venti anni di Berlusconi, sono stato più felice che infelice. Non sono stato infelice a causa di Berlinguer, non sono stato felice a causa di Berlusconi. Anzi, molti dei legami tra vita privata e vita pubblica hanno fatto in modo che Berlinguer rendesse meno infelice la mia giovinezza, e Berlusconi rendesse meno felice l'età adulta. Però si può essere infelici nonostante si creda in qualcosa, e si può essere felici nonostante si detesti qualcosa. [...]
Con il compromesso storico, Berlinguer aveva deciso di occuparsi di tutti gli italiani, anche quelli molto diversi dai comunisti. Con l'alternativa democratica, aveva scelto di occuparsi soltanto dei comunisti, di dividere il campo tra noi e gli altri, tra i giusti e gli ingiusti. Da questa divisione è scaturita tutta la storia negativa della sinistra italiana nei decenni successivi.
Noi pensiamo sempre che c'è stato un passato migliore, in cui le persone si occupavano, tutte, di questioni importanti. Pensiamo che siano i nostri tempi a essere superficiali, perduti. È questa certezza che ha reso saldo il nostro istinto reazionario, in qualsiasi spazio di vita. Era meglio prima.
Quelli che decidono di andarsene da questo Paese, o semplicemente dicono per tutta la vita di volerlo fare, è perché si vogliono salvare.
Io invece resto qui. Perché non mi voglio salvare.
 Da quando è uscita al cinema la pellicola ispirata alla sua storia (Oscar come Miglior film quest'anno) non vedevo l'ora di guardarla, però prima volevo leggere il libro, comprato ormai mesi fa. Devo essere sincera: mi aspettavo molto di più, invece mi sono trovata tra le mani nient'altro che un'autobiografia, genere che ha reso piuttosto noiosa la lettura, purtroppo. Ho faticato molto per arrivare alla fine, a saperlo mi sarei dedicata subito al film, senza passare per il libro. Questo è quello che consiglio di fare a chi non ha sperimentato ancora né l'uno né l'altro, premettendo che comunque, come al solito, il film si discosta in alcuni tratti dalla storia vera che Solomon Northup, divenuto schiavo Platt, ci ha dolorosamente raccontato nella sua straziante autobiografia.
Da quando è uscita al cinema la pellicola ispirata alla sua storia (Oscar come Miglior film quest'anno) non vedevo l'ora di guardarla, però prima volevo leggere il libro, comprato ormai mesi fa. Devo essere sincera: mi aspettavo molto di più, invece mi sono trovata tra le mani nient'altro che un'autobiografia, genere che ha reso piuttosto noiosa la lettura, purtroppo. Ho faticato molto per arrivare alla fine, a saperlo mi sarei dedicata subito al film, senza passare per il libro. Questo è quello che consiglio di fare a chi non ha sperimentato ancora né l'uno né l'altro, premettendo che comunque, come al solito, il film si discosta in alcuni tratti dalla storia vera che Solomon Northup, divenuto schiavo Platt, ci ha dolorosamente raccontato nella sua straziante autobiografia.